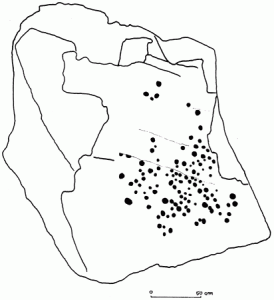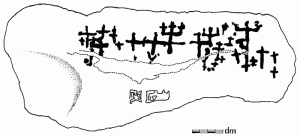Valle di Susa
Sant’Ambrogio di Torino (TO) : Sacra di San Michele della Chiusa
Storia del sito:
Alla fine del X secolo, più precisamente tra il 983 e il 987, un aristocratico dell’Alvernia, Ugo di Montboissier, stava tornando da un pellegrinaggio a Roma quando, per incitamento del papa Silvestro, fondò una nuova abbazia che dedicò all’arcangelo Michele, e scelse per essa un luogo straordinario sia dal punto di vista strategico che da quello simbolico, il monte Porcariano in Val Susa.
Il sito prescelto infatti sovrasta e domina la strada di Francia, importantissima via di transito di merci e pellegrini
Il toponimo, come quello del Caprasio, sull’altro lato della valle si riferiva agli animali che vi vivevano e fu presto modificato e nobilitato in quello di Pirchiriano, la cui pretesa radice greca pyr (fuoco) faceva riferimento ad una leggenda relativa ad un fuoco celeste che avrebbe avvolto la cima del monte indicando il luogo da scegliere per il nuovo edificio.
La collocazione sul monte ha poi un significato simbolico sul piano spirituale. Spesso il tema della montagna, del cammino in salita è stato assimilato al concetto di ascensione spirituale e/o ascesi mistica e a questo scopo spesso, come qui, la vetta del monte viene inglobata intatta nelle strutture del complesso architettonico come a Mont Saint Michel e a Saint Michel d’Aiguilhe (Le Puy). Inoltre la sua collocazione a metà strada fra gli altri due santuari dedicati in Occidente all’arcangelo, Mont Saint Michel sulla Manica e Monte Sant’Angelo sul Gargano, ne fa automaticamente l’ombelico, il centro del culto.
Nel primo secolo di vita, grazie ai lasciti di pellegrini facoltosi e agli interventi della curia pontificia, la nuova abbazia benedettina aumentò enormemente la propria potenza e le proprie ricchezze specialmente nella Francia centrale e meridionale. Si mostrò sempre fedele a Cluny e acerrima sostenitrice delle proprie autonomie contro i vescovi di Torino territorialmente competenti. Dalla Francia giunsero religiosi e un abate, Benedetto II, che fu tra i più accesi sostenitori del movimento riformatore, favorevole al centralismo papale e contrario ai vescovi di Torino, antiriformatori e filoimperiali. Nell’XI secolo San Michele della Chiusa era una leggenda culturale e spirituale. La sua biblioteca e la sua scuola di grammatica avevano una reputazione europea. L’aristocrazia di passaggio vi sostava spesso, lasciando ad ogni passaggio ricchissimi oboli, donando terreni e costruzioni. All’alba del 1200 San Michele era al massimo del suo splendore e si alleò con i Savoia in espansione al di qua delle Alpi. Il declino cominciò sul finire del XIV secolo. Nel 1375 l’abate Pietro si rifiutò di versare la sua quota per il sussidio straordinario richiesto dalla sede pontificia al vescovo di Torino. Quel rifiuto determinò un’inchiesta, avvelenata dallo scontro di potere in atto, che portò ad un’accusa di corruzione e lascivia. L’abate e i monaci a lui più legati vennero scomunicati. L’interdetto papale venne applicato nel 1379. Dopo due anni l’abbazia fu costituita in commenda ed affidata alla protezione di Amedeo VI di Savoia. Con la nomina dei commendatari, estranei alla vita monastica e talora laici, cominciò la lenta agonia dell’abbazia. Le guerre tra Spagna e Francia la videro spesso trasformata in fortezza e destinata a subire guasti e devastazioni. Nel 1622 restarono soltanto tre monaci e papa Gregorio XV ordinò la sospensione della vita monastica in san Michele. Fu Carlo Alberto nel 1836 a tentare di far risorgere a nuova vita il monastero. Vi furono trasportate ventiquattro salme di principi di Casa Savoia già tumulate nel Duomo di Torino e venne affidata in perpetuo ai Padri Rosminiani che vi rimangono tuttora.
Descrizione del sito:
Dal piazzale del parcheggio la prima costruzione che si incontra è il cosiddetto “sepolcro dei monaci”. Si tratta dei resti di un’antica costruzione che si riteneva fosse una cappella cimiteriale, ma appare più realistica oggi l’ipotesi che vede in questo edificio a forma ottagonale la riproduzione del Santo Sepolcro, quasi un anticipo ai pellegrini del Sepolcro di Gerusalemme; un luogo quindi di forte evocazione della morte e resurrezione di Cristo, ma anche un richiamo alla Gerusalemme celeste più ancora che a quella terrestre. Oltrepassata la foresteria, fabbricato coronato da merli ghibellini, e destinato ad ospitare i pellegrini in visita all’abbazia, ci troviamo di fronte la maestosa mole del monastero “vecchio”, un primo ampliamento di quello fatto costruire dal fondatore Ugo di Montboissier. Di antico rimangono solo le pareti esterne.
Al termine del viale ci troviamo di fronte un complesso di fortificazioni, che costituivano il baluardo avanzato di difesa dell’abbazia. E che attraversiamo passando per un portale difeso da una torretta. Siamo di fronte ora alla parte più imponente dell’abbazia. Belle pietre squadrate formano l’altissimo basamento grigio-ferrigno che sostiene le absidi verdognole della chiesa, con l’abside centrale coronata da una galleria ad archetti che è fra i migliori esempi di logge absidali romaniche. I monaci di San Benedetto intrapresero il ciclopico lavoro nella prima metà del XII secolo, proprio per creare lo spazio per ingrandire la preesistente chiesa.
Varcato il portone di accesso, che si apre nell’alto basamento, ci troviamo alla base dell’arditissimo scalone, che sale ripidissimo alla chiesa sovrastante, aggirando il pilastro colossale (m 18,36) che sostiene con i suoi quattro archi in croce la sovrastante chiesa. Un tempo questo atrio era assai sfruttato come sepoltura di uomini illustri: abati e benemeriti del monastero, per cui prese il nome di “scalone dei morti”. In cima all’ultima rampa, a metà strada tra l’ingresso e il portale della chiesa si apre il PORTALE DELLO ZODIACO. E’ così denominato, perché gli stipiti nella loro facciata rivolta verso lo scalone, sono scolpiti a destra con i dodici segni zodiacali e a sinistra con le costellazioni australi e boreali. Sosta di meditazione, stimolata dalla forza delle sue immagini e delle sue scritte epigrafiche prima di compiere l’ultimo sforzo ed accedere al portale della chiesa, privo a causa del rifacimento gotico, dell’iconografia tipica dei programmi apocalittici degli imponenti portali romanici. La sequenza è incentrata sulla meditazione dei frutti della giustizia e della malvagità. Le sculture sono accompagnate da una serie di iscrizioni il cui significato va ben al di là del generico “carattere didascalico moraleggiante” e mostrano chiaramente modi e mani diverse:
Nicholaus: autore oltre che dei due pilastri di alcuni capitelli (capitello con Caino ed Abele, capitello con figure di litiganti) e delle due basi figurate (una con leoni, l’altra con grifoni);
Maestro di Rivalta: tagliapietre anonimo di estrazione lombarda operoso altrove in Piemonte (capitello con la lussuria, capitello con sirene e di quello con Sansone che abbatte il tempio);
Pietro da Lione, raffinatissimo artista che ha lasciato la sua firma su un altare marmoreo della cattedrale di Susa.
A destra salendo l’ammonizione a compiere il bene per essere apparentati allo “iustus Abel” nella salvezza e non essere travolti dall’ira del Signore.
A. Quattro colonnine: due interne e due esterne di cui due elegantissime tortili sostenute da quattro piedistalli marmorei, due senza decorazioni, uno floreale e uno ornato da leoni dalla coda fogliata che stanno prendendo in bocca una palmetta, simbolo della vittoria in generale e, in questa accezione, simbolo della vittoria di Cristo sulla morte (Leone = Cristo che vince la morte = resurrezione. Già Isidoro da Siviglia aveva indicato nel leone una rappresentazione di Cristo e/o ruolo di difensore del sacro. Il leone infatti è sì un animale che dà la morte, ma la morte è un passaggio ineliminabile per accedere alla seconda vita).
B. Stipite: Nel mezzo fra le quattro colonnine è rappresentata la totalità del cosmo organizzato.
Lato verso lo scalone: Le figure delle dodici costellazioni zodiacali sono effigiate in undici cerchi formati da due rami intrecciantisi. I cerchi sono undici perché il terz’ultimo verso il basso porta due segni. Ogni figura ha il suo nome a fianco, inciso a stampatello con minuscoli fregi. Ecco i nomi letti dall’alto in basso e corrispondenti ai dodici mesi dell’anno da gennaio a dicembre: Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagitarius, Chapricornus.
Lato interno: cosiddetto “tralcio abitato”, in realtà, un albero che affonda le sue radici nella bocca di un mascherone rovesciato, simbolo del mondo sotterraneo, così come la chioma esprime quello superiore o celeste, segno di perpetua rigenerazione e quindi ancora una volta della costante vittoria sulla morte. Inerpicati tra i rami esseri umani e animali alati e non ma soprattutto in alto un piccolo bambino nudo, l’unico in posizione frontale che pare sovrintendere a tutto quell’affannarsi in salita. Esso ci riporta in mente la profezia della nascita di Cristo in Isaia 11: “et egredietur virga de radice Jesse, et flos de radice eiusascendet, et requiescet super eumspiritum Domini…” ai bordi stanno questi due versi che terminano con il nome dell’autore: “Vos qui transitissursumvel forte reditis/voslegite versus quosdescripsit Nicholaus” (Voi che andate in su o forse scendete, /leggete i versi che descrisse Nicolao).
C. Sette capitelli. Dall’interno 1. Floreale fantastico. 2. Simbolico. Scolpito su due soli lati. Contrapposizione fra lo “iustus Abel” ed il malvagio Caino. Lato 1 : Caino ed Abele indicato come il favorito dalla mano che sostituisce la figura di Jahvè fanno a Dio la loro offerta, come appunto dice la scritta che sta sopra “Munus Abel gratumconstatqueCainreprobatum (Il dono di Abele è gradito, ma quello di Caino viene respinto). Lato 2: Caino uccide Abele (violenza) per suggestione di una figura demoniaca alle sue spalle che si afferra con ambedue le mani una lingua smisurata tentando di strapparsela (menzogna) “Justus Abel moriturcumfratris fuste feritur” (Il giusto Abele muore ucciso dal bastone del fratello) 3. Floreale fantastico 4. Classicheggiante 5. Classicheggiante. 6. Simbolico. Capitello con personaggi nudi accosciati che si afferrano reciprocamente per i capelli (ira). scolpito su due lati assai corroso dal tempo, mostra tre persone furibonde che si strappano i capelli a vicenda. Rappresentazione dell’ira. La frase scritta sull’abaco recita “Hic locus est pacis causas deponite litium” (Questo è il luogo della pace – deponete ogni cagione di litigio) 7. Simbolico – scolpito su due lati – avventure di Sansone (tradizionale prefigurazione di Cristo). Lato 1: Sansone viene arrestato e ubriacato da Dalila. Lato 2: Sansone scuote le colonne del tempio dei Filistei.
A sinistra salendo l’invito alla meditazione sul peccato che non solo impedisce la salita al monte, cioè il processo di ascesi, ma scatena inevitabilmente la collera divina.
A. Tre colonnine: una sfaccettata e due cilindriche, sostenute da tre piedistalli. Due senza decorazioni, uno formato da due grifoni affrontati che appoggiano il becco d’aquila su una testa umana.
B. Stipite:
Lato verso lo scalone: è ornato di 16 costellazioni, racchiuse in dodici riquadri ciascuna con il suo nome scritto sul lato destro. Si susseguono dall’alto in basso , e cioè dalle prime, boreali, alle successive, australi. Rovinata la prima in alto mancante anche del nome, ecco i nomi delle altre 15: “Aquila, Delfinus – Pegasus, Deltoton, Orion, Lepus – Canis – Anticanis, Pistrix, Eridanus, Centaurus, cetus, Nothius – Ara, Hidra” Sul lato sinistro si legge questo verso “Hoc opus ortatursepius ut auspiciatur” (Questo lavoro invita ad essere guardato più volte). Il primo verso della serie, proprio di fronte a chi sale, gli altri versi sugli stipiti interni.
Lato interno: al centro cd. “tralcio abitato”, in realtà, un albero che affonda le sue radici nella bocca di un mascherone rovesciato, simbolo del mondo sotterraneo, così come la chioma esprime quello superiore o celeste, segno di perpetua rigenerazione e quindi ancora una volta della costante vittoria sulla morte. Sulla cornice superiore “Hoc opus intendat, quisquis bonus exi(t et intrat) – Questo lavoro lo interpreti chi è capace. Sulla cornice inferiore “Florescumbeluiscomixtos ce(rnite)” – Si vedono fiori mescolati a belve. Con riferimento alla profezia di Isaia.
C. Sei Capitelli: Dall’interno: 1.Nel lato centrale figure femminili tormentate da enormi serpenti che, strisciando sul loro corpo, addentano loro i seni e i piedi (la lussuria) ovvero due donne che allattano quattro serpenti, le code dei quali si mutano in teste che mordono i piedi delle donne stesse. Sulle facce laterali del capitello vi sono scolpiti un uomo venerando, forse sacerdote e un angelo (ovvero libera rappresentazione della Madre Terra). 2.Quattro falconi in cerchio (raffigurazione simile nel pulpito di S. Ambrogio a Milano) 3. Classicheggiante 4. Classicheggiante: rovinato da un fulmine 5. Leone con testa di drago e occhio feroce, in marmo bianco roseo 6. Tre tritoni: busti umani che s’innestano in code di pesce o sirene (raffigurazione simile nel pulpito di S. Ambrogio a Milano)
La trabeazione che incornicia ambo i lati è formata da tre pezzi marmorei, disuguali e mal connessi.
Oltrepassata la Porta dello Zodiaco ci troviamo allo scoperto sotto il gioco di quattro imponenti contrafforti e archi rampanti, ultimati negli anni 1935-1937, allo scopo di sostenere la parete meridionale della chiesa che dava pericolosi segnali di cedimento. Una lunga scala di pietra conduce alla porta d’ingresso della chiesa. Alla chiesa si accede attraverso un grandioso portale romanico, incorniciato da un gocciolatoio che termina a destra con la testa di un monaco incappucciato. Chiaramente gotici e aggiunti tardivamente sono ai lati gli archetti gotici trilobati. I battenti della porta furono fatti eseguire dal re Carlo Felice nel 1826. Incastrata in alto, a sinistra del portale, una lapide funeraria romana del I secolo d.C. Appena entrati all’interno della chiesa, in fondo alla navata destra, campeggia un grande affresco, attribuibile a Secondo del Bosco da Poirino (1505) che raffigura in tre scene distinte la sepoltura di Gesù, la Madonna morta (soggetto piuttosto raro) e la Madonna assunta. La chiesa attuale, iniziata all’incirca a metà del XII secolo per ingrandire la primitiva chiesa eretta da Ugo, fu ridotta in cattive condizioni dalle frequenti incursioni nei secoli di soldati piemontesi, francesi e spagnoli e subì numerosi restauri. Le absidi e la prima campata di archi, sostenuta da due enormi pilastri rotondi, tutti in serpentino verde, furono costruite per prime sopra l’atrio dei Morti, quando ancora si usava la chiesa di Ugo. Al fondo dell’abside centrale campeggia un colossale San Cristoforo del primo Cinquecento. Gli stipiti del grande finestrone dell’abside centrale sono ornati da sei statue, rappresentanti l’arcangelo Gabriele, la Madonna e i quattro Evangelisti. Nei capitelli viene rappresentato in tutta la sua varietà il fantasioso bestiario medievale. Sotto il pavimento della chiesa vi sono i resti della primitiva chiesa di San Michele. Contemporaneo alle costruzioni dell’ultima parte della chiesa (sec. XIII) è il massiccio campanile. Una torre alta fino al tetto della chiesa con gli angoli listate di lesene e le facce ornate di pilastrini pentagonali. La parte verso nord ovest è tutta occupato dai resti del c.d. monastero nuovo che si elevava per 5 piani ed era destinato ad ospitare i monaci nel periodo di maggior splendore dell’abbazia. Fu il primo a rovinare, tanto che una stampa del 1682 lo mostra già rovinato quasi come noi ora lo vediamo.
Informazioni:
Consultare il sito www.sacradisanmichele.com ; tel. 011 939130 ; e mail: info@sacradisanmichele.com
Links:
http://www.sacradisanmichele.com
http://it.wikipedia.org/wiki/Sacra_di_San_Michele
Bibliografia:
ROMANO G. (a cura di), La Sacra di san Michele. Storia, arte, restauri, Torino, 1990
A.SOLARO FISSORE, Simbolismi ascensionali in una meta di pellegrinaggio: il caso di San Michele della Chiusa, in SERGI (a cura di), Luoghi di strada nel Medioevo, Scriptorium, 1996
Per saperne di più, vedere l’ampia bibliografia nel sito www.sacradisanmichele.com.
Fonti:
Fotografie 1 e 2 da wikimedia; foto 3 e 4 da archivio GAT.
Data compilazione scheda:
15 aprile 2002 – aggiornamento giugno 2014
Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:
Mauro Marnetto – Gruppo Archeologico Torinese
Sant’Ambrogio di Torino (TO) : Resti del Borgo e del Castello
Storia dei siti:
La prima menzione di S. Ambrogio è del 1098, in un documento redatto nei claustra, cioè il complesso degli edifici monastici, dell’abbazia di S. Michele. Un diploma del 1111 dell’imperatore Enrico V cita “la strada pubblica che dalle montagne attraverso il borgo di S. Ambrogio giunge a Roma”: era quindi un insediamento di diretta emanazione e base logistica e amministrativa dell’abbazia.
IL CASTELLO – La prima attestazione scritta del “castello dell’abate clusino nel borgo di S. Ambrogio” risale al 1266, ai tempi dell’abate Decano, ma la sua origine è precedente, come si è rilevato nelle varie fasi edilizie trovate nel corso delle recenti campagne di scavo condotte nell’ambito del cantiere di restauro e di trasformazione del castello in struttura ricettiva.
Il Castello ebbe funzione prevalentemente politico-amministrativa di raccordo tra l’Abbazia, isolata sul monte, e l’area della valle su cui essa esercitava il proprio potere temporale; nel XIII-XIV secolo fu la sede del tribunale dell’abate, vi risiedeva con la scorta armata il vicario che governava per conto dell’Abbazia. A seguito dei gravi danneggiamenti inferti nel 1368 dalle truppe di Filippo d’Acaia, fu riparato e provvisto di caditoie e di una bertesca d’angolo. Dal 1533 al 1559 subì l’occupazione prima degli Spagnoli, poi dei Francesi e infine passò ai Savoia, che lo rinforzarono dotandolo di artiglieria leggera e di un buon numero di soldati. Tra Sei e Settecento fu ridotto allo stato di rudere da guerre e battaglie; divenne cava di materiali da costruzione e fu invaso dalle abitazioni private.
IL BORGO di Sant’Ambrogio, il cui nucleo storico è la piazza IV Novembre, era protetto da un’ampia cinta muraria e da due torri quadrate, dette della dogana e del feudo; la sua posizione lungo la Via Francigena ne facilitò lo sviluppo come centro commerciale: vi abbondavano botteghe, locande e un ospedale per i pellegrini gestito dai monaci dell’abbazia. Il lato occidentale delle mura fu ricostruito dopo le distruzioni degli Inglesi del 1368. Nel corso dei secoli il potere dell’Abbazia si affievolì e il controllo del borgo passò ai Savoia. Tra il XV ed il XVIII secolo il paese fu coinvolto nelle guerre tra i Savoia e la Francia e l’episodio più noto è la battaglia del 10 luglio 1630 tra l’esercito di Carlo Emanuele I e i francesi del duca Montmorency, presso Avigliana.
Descrizione dei siti:
Il comune di Sant’Ambrogio conserva i resti dell’antico borgo medievale: tre case presentano ancora muratura a spina di pesce, poi integrate nella CINTA MURARIA costruita a scopo difensivo con pietre da spacco e laterizi legati con strati di malta; Queste mura formano un quadrilatero irregolare imperniato nell’angolo sud-ovest sulla chiesa di S. Giovanni Vincenzo, mentre una torre cilindrica sorge sull’angolo nord-ovest; le due porte di ingresso si aprivano a cavallo della strada di Francia, asse di attraversamento dell’abitato. All’interno del borgo, in un cortile che si affaccia sulla via centrale, sono visibili i resti di un edificio pubblico con porticato al piano terra, di cui si conservano due arcate, sostenute da un pilastro sormontato da capitello a foglie lisce, e la parete orientale con una bifora decorata a pilastrini e capitelli. La pregevole fattura di qeste strutture fa pensare alla curia o al broletto del borgo.
La TORRE CIVICA risalente al XII secolo circa sorge accanto alla porta nord-est del borgo. A base quadrata, alta circa 15 m, a più piani, terminava con una merlatura in parte ancora visibile.
Dell’antica CHIESA DI SAN GIOVANNI VINCENZO (cui viene attribuita la fondazione della Sacra) non rimane oggi che l’imponente CAMPANILE in pietra in stile romanico, edificato intorno all’XI secolo e successivamente rimaneggiato; il resto dell’edificio è stato infatti ricostruito nel XVIII secolo in stile barocco, su progetto dell’architetto Bernardo Vittone. La torre campanaria presenta una base quadrata e un’elegante bifora con capitello a foglia d’acqua in pietra verde. All’interno un locale con volta a crociera e una scala a chiocciola in pietra.
Nella FRAZIONE SAN PIETRO sorgono i resti dell’antica chiesa omonima, oggi nascosta tra le case e parzialmente inglobata in una costruzione civile: ne restano le tre absidi, che risalirebbero all’ XI secolo e che hanno un’ampiezza di 12 metri.
Descrizione dei ritrovamenti:
CHIESA DI SAN GIOVANNI VINCENZO. L’originaria chiesa del borgo è stata ritrovata durante due interventi archeologici effettuati all’interno della parrocchiale settecentesca e al di sotto della piazza IV Novembre, dove al termine dei lavori è stata riportata sul selciato la pianta dell’edificio antico, disegnata con lastre di pietra. Ruotata di novanta gradi rispetto all’attuale, la prima chiesa si sviluppava in lunghezza per circa 24,80 m ed è ricostruibile nelle forme di una basilica a tre navate, separate da pilastri a sezione rettangolare e concluse da tre absidi semicircolari. La facciata, marcatamente obliqua, prospettava sul sentiero di salita a S. Michele. Il tetto doveva essere a capriate lignee; la mensa dell’altare centrale poggiava su un robusto basamento in muratura. Le caratteristiche planimetriche e di tecnica muraria permettono di attribuire l’origine di questa chiesa all’XI secolo. A partire dal XII secolo le accresciute esigenze pastorali degli abitanti del borgo formatosi intorno al complesso monastico e il trasferimento da Celle a S. Ambrogio delle reliquie di san Giovanni Vincenzo, beato eremita del monte Caprasio, indussero ad ampliare la chiesa con il raddoppio della navata laterale nord, la costruzione di un grande campanile e la creazione di un nuovo e profondo coro. Oltre alla torre campanaria, che alla base costituiva la cappella terminale della navata nord, si è fortunosamente conservato in alzato un tratto della nuova parete settentrionale della chiesa. L’abside del XII secolo è invece riaffiorata all’interno dell’attuale parrocchiale ed è risultata occupata da tombe quasi esclusivamente riservate ai bambini. Questa particolarità farebbe pensare a una devozione popolare che poneva le anime dei piccoli defunti sotto la protezione delle venerate reliquie di san Giovanni Vincenzo, al quale fu attribuito dal suo biografo il miracolo della resurrezione di un bambino e che viene citato come titolare della chiesa nei documenti scritti a partire dal 1233. (Vedi piantina ricostruttiva nell’allegato.)
CASTELLO. Le indagini archeologiche hanno rivelato come l’elemento più antico del castello fosse il torrione circolare costruito direttamente sulla roccia nel punto più elevato del sito, del quale rimangono i primi corsi di fondazione e una piccola parte dell’alzato. Associati alla torre sono alcuni muri realizzati con la tecnica a “spina pesce”, situati subito a nord, verso la zona pianeggiante. In un momento successivo la torre venne circondata da una cinta a pianta quadrangolare, della quale si conservano gli alzati, il portale e le grosse mensole in pietra che reggevano il cammino di ronda. La struttura fu successivamente ampliata verso valle, fino a raddoppiare il suo originario perimetro, e arricchita nel corso dei secoli XIV e XV da elementi costruiti in laterizi, come la bertesca, il torrino circolare nell’angolo sud, e i merli a coda di rondine. (Notizie tratte dal testo in allegato)
Vedi ALLEGATO: sambrogio 2010
Informazioni:
Nel centro storico si trovano i resti del borgo medievale.
Da P.za IV Novembre, a lato della Chiesa parrocchiale, inizia l’antica via (un tempo una mulattiera) tra l’Abbazia di San Michele della Chiusa (vedi scheda) ed il paese di Sant’Ambrogio. Salendo si osservano, sulla destra, i resti del castello Abbaziale; arrivando alla frazione San Pietro, ciò che rimane dell’antica chiesa. Comune, tel. 011 9324411
Links:
https://www.comune.santambrogioditorino.to.it
Fonti:
Fotografia in alto da http://www.torinomedica.com e altri siti; foto in basso (campanile S. Giovanni) dal sito, non più esistente dal 2015, della Provincia di Torino.
Data compilazione scheda:
18/12/2007- aggiornam. 2010 e giugno 2014
Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:
Angela Crosta – G.A.Torinese
Sant’Antonino di Susa (TO) : “Pera ‘dle Masche (Roca ‘dle Faie)”
Storia e descrizione del sito:
Il nome locale è Pera ‘dle Masche, cioè pietra delle streghe, invece il nome riportato in letteratura, Roca ‘dle Faje, cioè roccia delle Fate, è frutto di errata trascrizione.
Il masso, di notevole mole, è in posizione naturale e sovrasta la mulattiera sottostante, che conduce a Folatone. La roccia è uno gneiss occhiadino con feldspato potassico, quarzo e mica chiara.
La superficie incisa, liscia e piana, inclinata di 15°, misura 260 x180 cm e presenta linee di fenditura naturali. La roccia reca incise 131 coppelle che si presentano regolari e diametro da due a sette cm. Alcune coppelle hanno una sezione quasi conica e sono più marcatamente incise, mentre la maggior parte di esse presenta la classica sezione emisferica. Sembrano disposte in ordine sparso, ma presentano tuttavia allineamenti in linea curva.
Informazioni:
Il masso si trova in località C. Gattero a 600 m s.m., borgata Cresto, a poca distanza dal confine comunale tra Sant’Antonino e Vaie
Link:
http://www.rupestre.net/archiv/2/ar22.htm
Bibliografia:
A. ARCA’, A. FOSSATI (a cura di), Sui sentieri dell’Arte Rupestre: le rocce incise delle Alpi. Storia, ricerche, escursioni. Gruppo Ricerche Cultura Montana – Cooperativa Archeologica Le Orme dell’Uomo, CDA, Torino, 1995
Fonti:
Notizie e fotografie tratte dal sito sopra citato.
Data compilazione scheda:
5/7/2007 – aggiornamento giugno 2014
Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:
Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese
San Giorio di Susa (TO) : Incisioni rupestri del Gravio
Storia e descrizione del sito:
Il masso di calcescisto misura 383 x 185 cm. Al centro vi è una grossa fenditura con foro da mina, segno di un tentativo di scasso o di distruzione. Anche se la pietra era già nota nella zona, fu segnalata solo nel 1967, con vivaci polemiche circa l’attribuzione della “scoperta”, e con proposte di interpretazione quanto meno fantasiose.
Le incisioni sono: 15 croci unite, 9 croci singole, 3 croci a candelabro, croce peduncolata, 12 coppelle, 3 canaletti, scritta moderna. La parete incisa, rivolta a nord, presenta principalmente grosse croci, spesso unite per il braccio orizzontale, e a volte per quello verticale. I canaletti risultano dall’unione di tali croci. Le coppelle, tranne sei isolate, sono in rapporto con le croci, costituendone l’estremità. Molto interessanti le tre croci ramificate, di cui quella centrale, che spicca maggiormente, presenta tre ulteriori crocette sulle estremità delle ramificazioni. Simili a quelle del Gran Faetto, sul corrispondente versante della Val Chisone (distrutte da recente atto vandalico).
Lungo il sentiero di accesso sono presenti vari gruppi di incisioni, per di più coppelle, in particolare a Pois.
Informazioni:
Il masso inciso si trova in località rifugio Gravio a 1380 m s.m., presso il sentiero, a pochi metri dal torrente Gravio, che segna il confine comunale tra San Giorio e Villarfocchiardo.
Link:
http://www.rupestre.net/archiv/2/ar23.htm
Fonti:
Notizie e fotografie tratte dal sito sopra indicato
Data compilazione scheda:
6/7/2007 – aggiorn. maggio 2014
Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:
Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese
San Giorio di Susa (TO) : Castello
Storia del sito:
Sull’origine di San Giorio e del suo castello mancano dati precisi; si può ipotizzare l’esistenza di un fortilizio romano sulla collina morenica sulla quale sorge il paese, luogo di importanza strategica. Avvalorano questa ipotesi i ritrovamenti di monete dell’imperatore Massenzio e di una pietra miliare romana, che conferma l’esistenza della strada consolare romana sul lato destro della Dora Riparia.
Il primo documento che cita in modo esplicito il paese di San Giorio è del 1001; in esso l’imperatore Oddone III conferma al marchese Olderico Manfredi la terza parte di Susa e di altri paesi tra i quali “Sanctus Georius”.
Il nucleo più antico del castello, quello superiore, risale al X–XI secolo. Nel 1029 fu donato dal marchese Olderico di Susa all’Abbazia di San Giusto. Gli abati lo cedettero ai Bertrandi sul finire del 1200.
Imponente la torre cilindrica, che sorge all’angolo nord-ovest del castello superiore: in origine nella torre doveva trovare rifugio soltanto un guardiano; si accedeva al primo piano attraverso una bertesca, oggi andata perduta, di cui rimane un troncone di trave che ha dato luogo alla tradizione del “gibet”, cioè la forca patibolare. Un documento del 1226 ci attesta che qui esisteva un ricetto per gli uomini del borgo, oltre al nucleo del castello, ma senza il maschio. Nel 1330 i Bertrandi, divenuti feudatari di San Giorio, apportarono numerose e sostanziali modifiche al castello originario trasformandolo in una fortezza e costruirono il maschio.
Il castello inferiore sorse nel corso dello stesso secolo e doveva essere costituito da un grande locale centrale semiaperto con funzione di cortile d’arme e da una torre quadrata. In un secondo tempo, inoltre, fu costruita all’esterno della cinta muraria una casaforte con funzioni di prima difesa.
Nella prima metà del XV secolo, persa gran parte della propria potenza, i Bertrandi furono costretti a cedere i loro diritti sul borgo e sul castello di San Giorio: l’11 marzo del 1410 il conte Amedeo VII investì Giovanni Aprile, detto Griffon, della metà del castello e del borgo: si iniziò la suddivisione del feudo che in seguito si spezzetterà ulteriormente. Ai Bertrandi successero diversi feudatari: i d’Avrieu, gli Aschieri di Susa, i Parpaglia di Revigliasco, i Calvo di Avigliana, i Falconery, i De Chignin di Villarbasse, i Confalonieri, i Bartolomei, gli Acquabianca, i D’Allemand, i Bonino, i Grosso di Lione, i Carroccio, Emanuele di Savoia che lo donò poi al fratello, il quale a sua volta lo passò al colonnello Ressano di Pinerolo che aveva combattuto valorosamente contro gli assalti dell’esercito di Luigi XIII. Fu poi la volta dei Canalis di Cumiana, dei Faussone di Nucetto, e infine di Giuseppe Prever, un dottore in legge giavenese che nel 1795 ottenne il titolo di barone di San Giorio. Nel ‘700 i signori locali risiedevano altrove e si facevano rappresentare da un castellano o podestà attraverso il quale amministravano il paese. Il feudo venne abolito nel 1799 in conseguenza della Rivoluzione francese.
Quanto al castello, in seguito all’introduzione delle armi da fuoco ed al mutamento della tecnica d’assedio, subì alcune modifiche che tuttavia non ne alterarono l’aspetto: ampliato nel XV secolo con il rafforzamento della potenza difensiva della costruzione, ristrutturato nel 1640, il maniero non venne però adeguato ad affrontare i cannoni e alla fine del XVII secolo decadde in modo definitivo. In quel luogo si accamparono nel 1690 ventimila uomini dell’Armata di Vittorio Amedeo II, diretti a Susa per difendere la città dai Francesi. E nel 1691 le truppe del generale Catinat presero d’assalto tutta la zona incendiando, distruggendo e facendo molti prigionieri. Il castello venne quasi completamente distrutto e le sue macerie usate come materiale da costruzione.
Parte dell’edificio del castello superiore è stata recentemente ricostruita ed adibita ad abitazione dai proprietari.
Nel 2001, a cura di nove associazioni locali, è stata predisposta l’illuminazione del sito.
Descrizione del sito:
L’area fortificata, ad oriente dell’attuale chiesa parrocchiale, era circondata da un muro di cinta, oggi quasi scomparso. La chiesa parrocchiale fu riedificata nel XIX secolo e dell’antica chiesa rimane il solo CAMPANILE romanico, risalente al secolo XI, che termina con due piani di bifore.
Al castello superiore si accede per mezzo di una strada che si diparte dalla antica “via francigena” che attraversa l’abitato dopo aver fiancheggiato il lato meridionale della collina. La porta principale, anticamente difesa da un’antiporta quadrilatera e merlata, è sul lato orientale, mentre sul fianco sinistro c’è un’angusta postierla. Oltre la porta vi è uno spazioso cortile chiuso da un muro eretto sul ciglio roccioso del colle.
Il castello è dominato dalla mole della torre rotonda del X secolo, sopravvissuta insieme a resti della cinta muraria; invece il castello inferiore del XV secolo è ridotto a pochi ruderi.
Informazioni:
Il castello è di proprietà privata, in località Castello. Comune tel. 0122 49666
>
Link:
http://www.comune.sangioriodisusa.to.it/turismo-e-sport/cosa-visitare/
Data compilazione scheda:
02/03/2006 – aggiorn. maggio 2014
Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:
Angela Crosta – G. A. Torinese
San Giorio di Susa (TO) : Cappella di San Lorenzo (o del Conte)
Storia del sito:
L’area su cui sorge questa antica cappella era dedicata al culto, e quindi sacra, fin dal 500-400 a.C. Lo dimostra la roccia coppellata rinvenuta a sud dell’abside. Con l’avvento del cristianesimo la zona venne purificata e continuò ad essere un punto di riferimento spirituale per il paese.
Nel 1328 Lorenzetto Bertrandi, castellano di San Giorio, fece erigere questa cappella cimiteriale dedicandola al suo protettore San Lorenzo. Volle che fosse bellissima e la fece completamente affrescare sia all’esterno che all’interno da un pittore franco-piemontese. Della decorazione pittorica esterna ormai non rimane che un frammento sul lato sud, ma gli affreschi interni, sono stati restaurati nel corso dell’anno 2000.
Descrizione del sito:
La lettura teologica degli affreschi, si snoda in un percorso che tratta i temi della Salvezza, della Redenzione e della vita santa: il sacrificio di Cristo sulla croce ha reso possibile la redenzione dal peccato. Gli affreschi interni presentano scene della vita del Cristo (Annunciazione, Natività, Ultima Cena, Crocifissione), le vicende della vita di San Lorenzo, la raffigurazione della leggenda dei tre vivi e dei tre morti, Sant’Orsola e le Undicimila Vergini, la cacciata di Adamo ed Eva dall’Eden. All’esterno, sulla fiancata sud, è presente una raffigurazione di S. Cristoforo e l’Adorazione dei Magi.
La maniera pittorica risente dell’influenza giottesca (nel 1300 circa il Maestro era attivo a Milano) tanto che la Crocifissione ricorda quella della Cappella degli Scrovegni a Padova, ed inoltre presenta delle rifiniture ottenute con la foglia d’argento, ora scomparse, che impreziosivano le armature dei soldati ed i loro elmi.
Informazioni:
La Cappella fa parte del circuito del Museo Diocesano di Susa. Tel. 0122622640 – email:museo@centroculturalediocesano.it
Link:
http://www.vallesusa-tesori.it/it/luoghi/san-giorgio-di-susa/cappella-di-san-lorenzo
https://www.facebook.com/AssociazioneJonas/photos/pcb.960823525323851/960822811990589
Fonti:
Immagini dal sito sopra indicato, dove vi sono altre foto degli affreschi della cappella.
Data compilazione scheda:
02/03/2006 – aggiornam. maggio 2014
Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:
Angela Crosta – G. A. Torinese
Salbertrand (TO) : Chiesa di San Giovanni Battista
Storia del sito:
Nel villaggio romano di Sale Bertae, il Borgo di Berta, sin dal 1057 si ha notizia della Parrocchiale che venne donata alla Prevostura di Oulx dai marchesi Oddone ed Adelaide. Di questa chiesa romanica oggi non restano che parte dei capitelli e la base della torre campanaria.
L’edificio venne rifatto in stile tardogotico nel 1506-36 ed è considerato il più rappresentativo esempio di arte religiosa delfinale in alta Valle di Susa. Nel Settecento al campanile vennero aggiunti tre piani. L’edificio è preceduto da un elegante protiro, unico in Piemonte, e all’interno conserva affreschi dal XIV al XVI secolo.
Descrizione del sito:
Il protiro è retto da pesanti colonne in pietra ottagonali. Il portale in pietra, scolpito da Matteo Rode nel 1512, è formato da due fasci di slanciate colonnine su cui poggia un arco a tutto sesto inscritto in uno carenato che culmina con un giglio di Francia. I Rode (o Roude), famiglia proveniente da Melezet, firmarono molte opere e edifici tra la fine del XV secolo e l’inizio del XVI. Caratteristica di questo portale è l’unione di elementi di tradizione tardoromanica (il portale ad anelli) con elementi franco-delfinali.
Al muro esterno della navata destra poggia il campanile a sette piani.
L’interno della chiesa è a tre navate (delle quali quella centrale notevolmente più ampia) scandite da colonne di pietra e con volte a crociera con costoloni in pietra locale a vista. Le navate laterali, più corte della principale, sono suddivise in tre campate ciascuna nelle quali in passato erano collocati altari minori. L’altare maggiore in stile barocco è molto elaborato e scenografico; nell’Archivio Storico Comunale di Salbertrand si conserva una nota di pagamento per il retable al Maestro Jean Faure di Thures nell’anno 1667.
I CAPITELLI hanno caratteristiche e datazioni differenti. Su un capitello è riportata la data del 1506 e altri, affini a questo nelle colonne al centro della navata, richiamano la contemporanea scultura lapidea presente soprattutto nei fonti battesimali: motivi araldici, gigli di Francia e delfini simbolo del Delfinato, motivi fitomorfi di impronta rinascimentale, piccole teste umane, soprattutto angolari, molto semplificate. Gli altri capitelli, completamente differenti stilisticamente, presentano volute ioniche con foglie d’acanto (terzo pilastro a sinistra), teste a maschera greca, con baffi o con elmi (si vedano i pilastri della stessa cappella, a sinistra della navate centrale); molto probabilmente quando, nel 1506, venne ricostruita la chiesa, si riutilizzarono elementi decorativi, in particolare i capitelli, del precedente edificio romanico.
AFFRESCHI. Anticamente all’esterno, sulla parete destra, vi era la rappresentazione su tre registri dei Vizi, Virtù e Pene infernali oggi totalmente illeggibili: nella lunetta che sormonta il portale vediamo una Pietà di difficile lettura per le pesanti ridipinture.
All’interno, nelle lunette, vi sono affreschi, fra le poche opere della valle firmate e datate da Giovanni Dideri di Avigliana nel 1508.
A sinistra rimangono i frammenti di un Giudizio Finale; sulla parete della navata sinistra è inserito in un riquadro sant’Eligio del 1508; in fondo a questa navata, sormonta l’altare una lunetta recante una Pietà cinquecentesca, mentre nella porzione sottostante di muro sono raffigurati la Madonna e Gesù giovane, di fine Trecento.
Interessante la raffigurazione di sant’Eligio che veniva normalmente rappresentato come maniscalco o orafo. Egli infatti avrebbe lavorato presso la bottega di un fabbro prima di divenire cesellatore ed autore di capolavori come il sarcofago di San Martino di Tours, il mausoleo di Saint Denis e il trono di re Clotario II. A Salbertrand (come alla Madonna del Rosario di Bernezzo, Val Grana) è l’iconografia più umile a prevalere: la scena del miracolo raffigura il santo nell’atto di riattaccare la zampa ad un cavallo; egli stesso l’avrebbe tagliata per ferrarla, risanando l’animale con il segno della croce.
Nella navata destra, affreschi del Dideri: la prima campata presenta episodi della vita di sant’Antonio abate e san Paolo eremita; la seconda campata è decorata con quattro figure di Santi (Rocco, Colombano, Cosma e Damiano); infine gli affreschi della volta dove due spicchi della terza campata presentano la Madonna di Misericordia in cui la Madonna-Chiesa con le braccia aperte accoglie sotto il suo manto fedeli e committenti e l’Assunzione di Maria.
Informazioni:
Rivolgersi al Parco Gran Bosco, tel. 0122 854720 ; email: parco.salbertrand@ruparpiemonte.it oppure Comune tel. 0122 854595, email: alpicozie@cert.ruparpiemonte.it
Links:
http://www.vallesusa-tesori.it/it/luoghi/salbertrand/chiesa-di-san-giovanni-battista
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_San_Giovanni_Battista_%28Salbertrand%29
http://www.parcogranboscosalbertrand.it
Fonti:
Fotografie da Wikimedia e dai siti sopra indicati.
Data compilazione scheda:
01/09/2006 – aggiornamento maggio 2014
Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:
Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese
Oulx (TO) : Torre delfinale
Storia del sito:
La Torre Delfinale, detta impropriamente “Torre Saracena”, non è menzionata nell’inchiesta papale del 1339, che mirava a un censimento dei beni delfinali per i quali era stata proposta una cessione al pontefice; è invece citata nel 1377, un trentennio dopo l’annessione del Delfinato al regno di Francia. L’analisi dendrocronologica, condotta sugli elementi in legno della torre, li riferisce tra il 1350 e il 1370 circa; quindi la torre dovrebbe essere stata costruita nel terzo quarto del XIV secolo.
La sua funzione era legata alla presenza dei funzionari regi sul territorio, non ad un uso militare. Questa ipotesi è suffragata da due atti notarili del 1425 e del 1438, relativi alla cessione della torre da un privato al curato di Oulx e successivamente da questi al Comune: in entrambi l’edificio è descritto ponendo l’accento più sul suo ruolo abitativo che difensivo. Sia gli atti citati che quelli del secolo successivo descrivono la torre racchiusa in una cinta muraria rettangolare; entro cui vi era anche un altro edificio con un piano fuori terra, in aderenza alla torre stessa sul fronte sud. Allo stato attuale della ricerca, tuttavia, non sono state individuate tracce di tale struttura.
Non si hanno notizie su quando l’importanza della torre venne meno, né sull’epoca in cui essa fu definitivamente abbandonata; era comunque già registrata come rudere in un consegnamento del 1735, mentre il catasto Rabbini del 1866 la indica come “torre diroccata”.
Lo stato precario dell’edificio indusse il cav. Luigi Des Ambrois di Nevache, ministro di Carlo Alberto, nato a Oulx, a richiedere la torre in enfiteusi perpetua, al fine di provvedere ad un intervento di restauro per preservarne i resti, senza alterarne le caratteristiche. La richiesta fu accettata dal Comune nel 1872. Successivamente alla morte del Des Ambrois la torre passò agli eredi, che solo in anni recenti hanno presentato formale rinuncia ai loro diritti restituendo il manufatto al Comune; dal 1978 è sottoposta a vincolo dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali del Piemonte.
All’inizio degli anni 2000, dopo decenni di abbandono, i segni del degrado erano diventati piuttosto evidenti, non tanto nella stabilità delle murature, quanto nella mancanza dei solai lignei, nel degrado diffuso dei lacerti di intonaco e nell’oblio che come la circostante vegetazione ne stava oscurando la visibilità al mondo esterno. Dal 2004 al 2007 sono stati eseguiti lavori di restauro e recupero dell’interno della torre, lasciando intatto il profilo esterno. Sono stati privilegiati gli interventi di tipo reversibile e di limitata invasività. Nuovi solai e camminamenti sono stati realizzati al fine di utilizzarla come sede espositiva per mostre ed eventi temporanei.
Scarica allegato Scheda_Torre_Oulx
Descrizione del sito:
La torre delfinale si presenta con un impianto quadrato (7,8 m di lato) e struttura muraria, realizzata con cura e perizia in materiale lapideo differenziato: cantonali in travertino, facilmente lavorabile e resistente al degrado, blocchi monolitici di quarzite per soglie e davanzali, e frammenti lapidei allettati in corsi regolari con abbondante malta di qualità a completamento della muratura.
Vi si accede attraverso una porta con arco a tutto sesto collocata al piano terra, in prossimità dello spigolo nord-est. Gli stipiti, l’archivolto e la muratura che circonda la porta sono di travertino, con conci lavorati in forma pentagonale a formare il sesto dell’arco di chiusura. La torre è coronata da merli semplici, sui quali era appoggiata la copertura che, con ogni probabilità, si presentava originariamente a padiglione con orditura lignea e manto di lose.
Al suo interno l’edificio era suddiviso in quattro livelli, raccordati da scale in legno, che sono stati ripristinati con il restauro grazie alla presenza dell’impronta dei solai e della risega che la muratura formava verso l’esterno in corrispondenza dell’imposta di ognuno di essi. Il piano terra aveva mansione di servizio, mentre il primo piano svolgeva la funzione di piano nobile: è caratterizzato da un grande camino con cappa sorretta da colonnine in pietra, addossato alla parete est, percorsa fino alla sommità dalla canna fumaria; lo fiancheggiano due finestre dotate di seduta in pietra. Il piano secondo era utilizzato per la notte ed era provvisto di latrina esterna a sbalzo e di feritoie per la difesa. Il terzo, infine, costituiva il piano di ronda ed era poco più in basso rispetto alla base dei merli.
Informazioni:
Sorge nel Borgo Vecchio del Paese, su uno sperone roccioso in posizione dominante sul territorio circostante, poco distante dalla Chiesa di Santa Maria Assunta, raggiungibile percorrendo il vicolo della Torre (da via Des Ambrois) oppure risalendo la scalinata del Jardin d’la Tour. Comune tel. 0122 831102
Links:
https://www.oulx.org/storia.php
http://www.vallesusa-tesori.it/it/luoghi/oulx/torre-delfinale
Fonti:
Fotografia dal sito www.oulx.org
Data compilazione scheda:
19/10/2010 -aggiornam- luglio 2014
Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:
Angela Crosta – G.A.Torinese
Oulx – Savoulx (TO) : Chiesa di San Gregorio Magno
Storia del sito:
La chiesa di Savoulx fu edificata nel 1451 (il decreto di erezione porta la data del 4 ottobre) e venne consacrata e aperta al culto nel 1454. Nel 1662 avvenne la ricostruzione dell’abside, senza riportare ulteriori interventi atti a modificare la chiesa. Un recente restauro (2003-2005), attraverso la rimozione dello strato di intonaco, ha riportato alla luce la lavorazione della pietra delle volte e, sulle pareti della navata laterale, alcuni affreschi risalenti al XV secolo con scene della vita di sant’Antonio abate.
Descrizione del sito:
La facciata della chiesa è di grande semplicità e viene ingentilita dal portale, opera locale, che ha nella parte superiore il complicato trigramma di Gesù (IHS), al centro della sigla S(anctus) G(regorius), titolare della chiesa e ai lati la data 1532. Lo stile architettonico generale della chiesa presenta elementi del romanico e del gotico, mentre nella parte absidale si denota un intervento barocco datato 1662.
L’interno della chiesa si presenta a due navate coperte da volte a crociera ogivali costolonate; un grande pilastro polilobato regge l’arcone che separa i campi della navata maggiore, mentre colonne in pietra con capitelli scolpiti reggono le due corrispondenti campate della navata minore. I sei capitelli figurati con tracce di policromia, databili all’epoca di costruzione della chiesa (metà XV secolo), presentano visi umani fortemente caratterizzati (ad esempio la testa di moro con le labbra molto sporgenti e un curioso turbante) e decorazioni naturalistiche (in particolare foglie d’acanto).
La navata centrale è illuminata da quattro finestre con feritoia centinata, davanzale inclinato e spalle oblique, poste in corrispondenza delle due campate sulle facciate nord e sud. L’abside poligonale è illuminata da tre grandi finestre monofore.
Sulle pareti della navata laterale sono presenti alcuni AFFRESCHI quattrocenteschi: una serie di sei riquadri suddivisi in tre registri decora la parete che ospita l’antico altare intitolato a sant’Antonio abate e raffigura scene della vita del Santo. Nel registro superiore si possono osservare: sant’Antonio, all’interno di una chiesa, ascolta le letture del Vangelo; sant’Antonio distribuisce i suoi beni ai poveri; al di sotto la scena di sant’Antonio mentre riceve l’abito monastico da un abate, circondato dai confratelli in preghiera; sant’Antonio, fattosi eremita, si reca nel deserto da san Paolo eremita e un centauro gli indica la strada. In basso: san Paolo eremita e sant’Antonio vengono nutriti da un corvo che porta loro del pane; i demoni tentano sant’Antonio nel suo eremitaggio nel deserto.
Sulla parete sinistra della navata laterale è posta una finestra, alla destra della quale vediamo una Pietà, mentre sulla sinistra è raffigurata santa Caterina d’Alessandria con i suoi attributi iconografici, la ruota dentata e la spada. In alto l’Eterno benedicente. Altri affreschi raffigurano, in fondo alla parete, scene della vita della Vergine, purtroppo in gran parte perdute: le scene più leggibili sono la dormitio Virginis e l’Assunzione. Nello sguincio di una finestra, infine, sono raffigurati a sinistra san Rocco e a destra un santo non identificato in quanto privo di attributi.
Nella chiesa vi è una vasca di pietra per l’acqua benedetta, datata 1545, con il giglio e il delfino di Francia che presenta alla base una decorazione a petali sormontato da archetti pensili. Il fonte battesimale ha una certa analogia con l’acquasantiera ed è probabilmente della stessa epoca. L’altare maggiore fu realizzato nel 1672. Il retablo venne commissionato per volere del vicario generale della Prevostura Allois nel 1669, terminato nel 1673; è attribuito a Jacques Jesse, maestro intagliatore di Embrun. La tribuna lignea reca la data incisa 1555.
Il CAMPANILE presenta le caratteristiche dello stile architettonico tipico dell’area dell’antico Delfinato, che intreccia elementi del gotico a motivi ancora romanici; molto snello e slanciato, è costruito in pietra con spigoli definiti da grandi blocchi squadrati. Le aperture a bifora e quelle a trifora dell’ultimo settore hanno colonnina e capitello a stampella in pietra, concluso da un coronamento di archetti pensili. Completa la struttura la guglia a base ottagonale, realizzata in blocchi di pietra squadrati. Il campanile è databile agli anni di costruzione della chiesa.
Informazioni:
La chiesa si trova nella frazione di Savoulx. Centro Culturale Diocesano di Susa tel. 0122.622640
Links:
https://www.oulx.or
http://www.vallesusa-tesori.it/it/luoghi/oulx/parrocchiale-di-s-gregorio-magno-savoulx
http://www.centroculturalediocesano.it
Fonti:
Scheda redatta da materiale fornito dal “Centro Culturale Diocesano” di Susa http://www.centroculturalediocesano.it
Fotografie dal sito www.vallesusa-tesori.it
Data compilazione scheda:
03/08/2006 – aggiorn. luglio 2014
Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:
Angela Crosta – Gruppo Archeologico Torinese
Oulx – Beaulard (TO) : Chiesa di San Michele Arcangelo
Storia del sito:
Di questo sito non si conoscono le origini, o meglio non vi sono certezze in merito. Può però essere databile all’XI–XII secolo. Notizie di prime comunità cristiane in loco vengono menzionate negli scritti intorno al X secolo. Si narra che una parte dei monaci della Novalesa dovette fuggire e riparò a Oulx ove trovò una comunità cristiana che annoverava molti fedeli. In seguito nella comunità si poté contare su delle “Plebes Martirum” e su due santi (san Giusto e Flaviano) che si rifugiarono in montagna proprio in questa zona, cioè dove ora sorge la cappella della Visitazione, in località San Giusto appunto. Di lassù videro le devastazioni e le razzie che venivano perpetuate dai Saraceni e decisero di scendere per contrastarle, giungendo così al martirio. È perciò possibile che a Beaulard esistesse già una chiesa e che essa venne distrutta dai Saraceni come molte altre nella vallata. È nel secolo successivo che si inizia a ricordare molto chiaramente la chiesa dedicata a San Michele in Beaulard, nel diploma con cui il Vescovo di Torino Cuniberto, nell’anno 1065, la donava alla prevostura di Oulx fondata da poco. È pertanto possibile che tale costruzione sia databile nell’XI secolo e che sia stata costruita dai Canonici Lateranensi della Prevostura, che grazie alle copiose donazioni erano riusciti a estendere la loro giurisdizione in tutta l’alta valle.
Descrizione del sito:
Dell’epoca sono visibili, in stile romanico, l’abside – ora trasformata in ingresso – l’arco trionfale ed i muri delle fiancate, in seguito aperti per allargare la chiesa e portarla a tre navate, ma che conservano in alto (nascosti dai tetti) gli antichi archetti pensili tagliati nel tufo. Nel sottotetto si possono scorgere anche le finestrelle romaniche a monofora. Il campanile che sorge di fianco alla primitiva abside e che ostenta i suoi bei paramenti di pietra è anch’esso in stile romanico, ma forse non coevo alla chiesa. Il confronto che si può fare per verificarne la veridicità è con il campanile della chiesa antica di Bardonecchia che si può dire coeva di San Michele. All’interno della chiesa di Beaulard si possono osservare, nell’antica abside un affresco del XV secolo raffigurante il Cristo pantocratore nella mandorla e al di sotto la teoria degli Apostoli; una vasca battesimale del 1501 ed un leggio del 1607.
Non bisogna ignorare che a Beaulard esiste anche un borgo che si chiama Cateau Boulard che prende il nome dal castello che nel periodo medievale, a nord dell’attuale borgo, presidiava la valle di Bardonecchia. Il sito venne poi inglobato in un Fortino dal Lesdiguières nel 1594. I resti del fortino e quindi del castello non sono più visibili. Nel 1454 viene costruita la chiesa parrocchiale intitolata a San Bartolomeo Apostolo. Essa conserva un altare e un portale risalenti al 1521.
Informazioni:
In frazione Beaulard. Parrocchia tel. 0122 99047
http://www.vallesusa-tesori.it/it/luoghi/oulx/chiesa-di-san-michele-arcangelo-beaulard
Fonti:
Immagini da www.vallesusa-tesori.it
Data compilazione scheda:
25 ottobre 2003 – aggiornam. giugno 2014
Nome del rilevatore e associazione di appartenenza:
Valter Bonello – Gruppo Archeologico Torinese